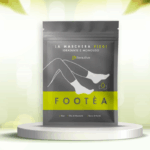Quando si pensa agli insetti che muoiono dopo aver punto, la prima immagine che viene in mente è quella delle api mellifere, famose per questa caratteristica unica. Tuttavia, tra le migliaia di specie di insetti pungenti, il fenomeno non è così diffuso come si potrebbe credere. Esplorando l’affascinante mondo degli imenotteri e delle loro diverse strategie di difesa, emergono dettagli sorprendenti sul comportamento e sulla biologia di questi piccoli ma temibili animali.
Perché alcune api muoiono dopo aver punto?
Tra gli imenotteri, le api (in particolare la specie Apis mellifera) sono note per morire dopo la puntura, ma questo accade principalmente quando l’ape punge un essere umano o un mammifero, non altri insetti. Il motivo sta nella struttura particolare del pungiglione: è uncinato e dotato di piccole spine rivolte all’indietro. Quando penetra nella pelle umana, rimane incastrato perché la nostra epidermide è abbastanza elastica da stringersi attorno alla base del pungiglione, impedendo all’ape di estrarlo senza strapparsi una parte dell’addome insieme al sacco velenifero. Questo trauma è letale per l’ape operaia, che muore poco dopo essersi separata dal proprio pungiglione.
Se però l’ape punge un altro insetto, la struttura cutanea di quest’ultimo permette spesso al pungiglione di essere ritratto, evitando così la morte dell’ape stessa. Questo meccanismo mostra come la letalità della puntura per l’insetto sia strettamente legata alle caratteristiche della vittima e non rappresenti una regola universale.
Altri imenotteri: vespe e calabroni hanno la stessa sorte?
Le vespe e i calabroni, pur appartenendo anch’essi all’ordine degli imenotteri, hanno sviluppato pungiglioni di tipo diverso. Questi insetti dispongono di un pungiglione liscio, cioè privo delle spine uncinanti tipiche delle api mellifere. Questo consente loro di pungere ripetutamente senza rischiare la vita, poiché possono estrarre e reinserire il pungiglione senza che si stacchi dal corpo.
Le vespe, a differenza delle api, sono spesso più aggressive e, se disturbate, possono infliggere più punture di seguito senza subire danni diretti dovuti al loro apparato di difesa. I calabroni (Vespa crabro), tra i vespidi più grandi d’Europa, seguono una biologia simile: pungono più volte e iniettano una quantità di veleno maggiore rispetto ad api e vespe comuni, risultando così più pericolosi per l’uomo, seppur non mortali per se stessi dopo la puntura.
Insetti che muoiono (quasi) solo dopo aver punto: casi eccezionali e casi negati
Chiarito che solo alcune api operaie sono inserite tra quegli insetti che muoiono sistematicamente dopo aver punto, si può essere tentati di chiedersi: esistono altre specie con una sorte simile? La risposta dei principali testi di entomologia e delle fonti scientifiche è no: la combinazione di pungiglione uncinato e morte dopo la puntura rappresenta una peculiarità quasi esclusiva delle api mellifere e delle loro più strette parenti all’interno del genere Apis.
I bombi, che appartengono allo stesso gruppo delle api (famiglia Apidae), possiedono un pungiglione privo di uncini. Possono dunque pungere ripetutamente senza conseguenze fatali per loro, esattamente come le vespe.
Tra i restanti imenotteri sociali come le formiche, esistono specie dotate di pungiglione (come la formica proiettile), ma anche queste non presentano la caratteristica di morire a seguito della puntura. Il pungiglione si utilizza più volte, sia in combattimenti tra individui della stessa specie sia per difendersi da predatori.
Nell’ordine degli imenotteri e negli altri insetti artropodi velenosi, quindi, il fenomeno riscontrato nelle api rappresenta un caso eccezionale e circoscritto. In altre famiglie o ordini, come i lepidotteri (farfalle e falene), i coleotteri (scarabei, coccinelle), i ditteri (mosche, zanzare), non esiste alcun tipo di pungiglione in grado di produrre questa dinamica.
Perché l’evoluzione ha scelto questa “soluzione estrema” per le api?
L’apparente paradosso di un organismo che sacrifica la propria vita come reazione di difesa trova una logica nel contesto sociale delle api. L’alveare è un superorganismo altamente organizzato, nel quale l’individuo operaio ha un valore relativo rispetto alla colonia. Difendere la regina, le larve e le riserve alimentari da un predatore o una minaccia è fondamentale: la morte dell’operaia non compromette la sopravvivenza del gruppo, ma la perdita della regina sarebbe catastrofica.
La potenza del pungiglione uncinato risiede nella capacità di rilasciare tutto il veleno attraverso il sacco velenifero e di continuare a iniettare tossine anche dopo che l’ape si è allontanata o è già morta. Questo rappresenta una formidabile difesa a beneficio dell’intera colonia, dissuadendo eventuali predatori dall’attaccare nuovamente lo stesso nido.
Risposte fisiologiche nei mammiferi e negli uomini
Nel corpo umano, la puntura d’ape provoca dolore immediato, arrossamento, gonfiore, e in soggetti allergici può indurre reazioni anafilattiche anche molto gravi. Il veleno d’ape è un mix di sostanze come istamina, fosfolipasi, ialuronidasi e chinine, dotate di azione emolitica, neurotossica e sensibilizzante sull’apparato immunitario. La presenza del pungiglione nella ferita implica la necessità di rimuoverlo il prima possibile, senza schiacciare il sacco velenifero.
- Morire dopo aver punto è quindi una caratteristica quasi esclusiva delle api mellifere operaie per ragioni di struttura anatomica e di strategia difensiva collettiva.
- Le vespe, i calabroni e altri imenotteri dotati di pungiglione, in genere, non vanno incontro a morte per questo comportamento.
- Non esistono altre famiglie di insetti note in cui la puntura sia letale per l’individuo che la compie.
L’osservazione del comportamento di questi insetti e la comprensione delle loro strategie difensive porta a vedere la puntura delle api mellifere come un sacrificio individuale a beneficio della società, un esempio unico di evoluzione spinta dalla complessità della vita comunitaria all’interno dell’alveare.